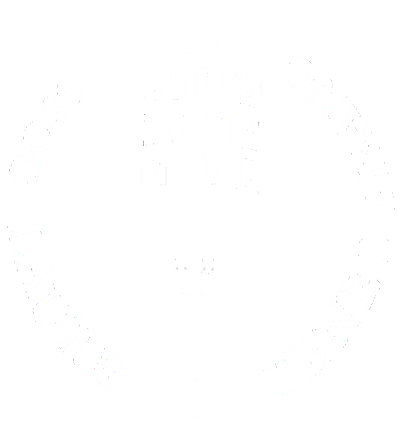È una storia di talenti che tornano a casa, quella che vede protagonisti tre fisici formati all’Università di Pisa. Francesco Volpe, fondatore della start-up francese Renaissance Fusion, ha scelto l’Italia per la prima espansione internazionale della sua azienda, acquisendo Phymtech, la società fondata nel 2012 da altri due alumni pisani: Francesco Ceccherini e Laura Galeotti.
Tutti e tre hanno percorsi che si intrecciano tra formazione pisana e carriere internazionali. Volpe, dopo gli studi a Pisa, ha fondato nel 2020 a Grenoble Renaissance Fusion, oggi azienda con circa 100 dipendenti e oltre 60 milioni di euro di finanziamenti, che sviluppa reattori a fusione nucleare basati sulla tecnologia Stellarator.
Ceccherini e Galeotti, entrambi laureati a Pisa, hanno invece costruito la loro esperienza ventennale negli Stati Uniti specializzandosi in modellazione matematica applicata alla fusione nucleare.
Ora i tre uniscono le forze in un progetto ambizioso: far nascere a Pisa un polo di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare che possa offrire opportunità ai giovani talenti italiani e creare un ponte tra il mondo accademico e quello industriale.
Abbiamo intervistato Francesco Ceccherini e Laura Galeotti per raccontarci questo ritorno a casa.
Dopo vent’anni di esperienza negli Stati Uniti nel campo della fusione nucleare, cosa vi ha spinto a tornare in Italia?
Gli Stati Uniti ci hanno offerto molto sia in termini di formazione che di opportunità e di questo siamo davvero grati. Quando abbiamo iniziato nel 2006 e per diversi anni successivi, quasi tutti i progetti privati legati alla fusione nucleare si trovavano negli Stati Uniti. Gli ultimi cinque anni hanno invece visto uno sviluppo di iniziative europee molto significativo e per certi aspetti anche inaspettato. Si è quindi creata per noi un’opportunità che abbiamo voluto cogliere. Questo ci permette da una parte di “riportare” in Europa e in Italia le competenze acquisite nel corso di tanti anni e dall’altra di poter dare un contributo allo sviluppo di nuove collaborazioni e connessioni all’interno del tessuto accademico-industriale italiano.
Voi vi occuperete di ricerca e sviluppo di un reattore di fusione nucleare Stellarator, alternativo al Tokamak. Potete spiegare in termini accessibili ai non addetti ai lavori quali sono le principali differenze e i vantaggi di questa tecnologia?
In entrambe le tecnologie, Tokamak e Stellarator, il plasma è confinato da campi magnetici. Nel Tokamak i campi magnetici sono in parte generati da bobine esterne e in parte dal plasma stesso; nello Stellarator invece i campi magnetici sono generati esclusivamente da bobine esterne, la cui progettazione e costruzione risulta però incredibilmente complessa. Un’altra differenza significativa è che lo Stellarator può funzionare in continuo, mentre il Tokamak funziona come una macchina impulsata che necessita di un restart a intervalli regolari. In breve quindi, lo Stellarator è molto più complesso da progettare e costruire ma più facile da operare; il Tokamak è più facile da progettare e costruire ma più difficile da operare.
Che ruolo ha avuto la formazione ricevuta all’Università di Pisa nel prepararvi per il vostro percorso di carriera?
Francesco Ceccherini: Per me ha avuto un ruolo fondamentale in quanto mi ha fornito non solo le competenze specifiche in certi settori, ma anche gli strumenti per affrontare in modo autonomo e sicuro ambiti del tutto nuovi rispetto ai corsi seguiti. Questo l’ho sperimentato sia negli anni del dottorato di ricerca in Germania che poi negli anni di lavoro negli Stati Uniti. Tornare dopo tanto tempo a lavorare nella realtà pisana penso sia una testimonianza del fatto che il legame con l’Università di Pisa non è mai venuto meno.
Laura Galeotti: La formazione che ho ricevuto dall’Università di Pisa è stata cruciale per la mia carriera, avendo svolto sia il percorso di laurea sia il dottorato di ricerca presso l’ateneo pisano. Oltre ad avermi fornito conoscenze specialistiche approfondite che sono state indispensabili per affrontare il lavoro quotidiano nell’ambito della fisica dei plasmi, mi hanno formato come ricercatrice. Mi è stato insegnato come si fa ricerca, a sviluppare il senso critico e la creatività, a lavorare proficuamente da sola e in team, a presentare i risultati in maniera efficace, permettendomi di affrontare il mondo del lavoro con serenità e sicurezza.
Quali sinergie potrebbero nascere con le università e i centri di ricerca italiani, a partire da Pisa?
Sicuramente ci sono numerose sinergie che possono essere attivate ed essere oggetto di collaborazioni, in quanto la fusione nucleare necessita di un amplissimo spettro di competenze e multidisciplinarietà. Si parte ovviamente dalla fisica dei plasmi e dall’ingegneria nucleare in tutti i suoi diversi aspetti per arrivare alla modellazione matematica, al supercomputing e all’intelligenza artificiale. L’impegno e lo sforzo richiesti per arrivare a macchine dimostrative sono tali che mettere insieme competenze e sinergie non è un’opzione ma una necessità.
Entro fine 2026 prevedete di assumere diversi collaboratori tra ingegneri e fisici. Quali competenze specifiche cercate e quale consiglio dareste a giovani studenti e laureati dell’Università di Pisa interessati?
Le competenze più cercate sono principalmente nella fisica dei plasmi e nella modellazione matematica e numerica. Ci sono comunque ampie disponibilità anche per diversi settori dell’ingegneria, con preferenza per l’ambito nucleare. Chiunque sia interessato a un potenziale inserimento può verificare in ogni momento sul sito ufficiale quali sono le disponibilità per i diversi profili, senza escludere la possibilità di una candidatura spontanea che sarà certamente considerata e valutata.
Intervista a cura di Maria Linda Pessolano