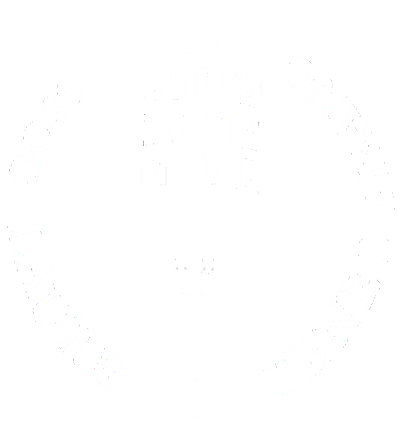Il 2 ottobre è stato ricordato Marco Santagata, attraverso alcune voci di persone che lo conoscevano bene. Nel cortile della Sapienza di Pisa sono rimbalzate memorie ed echi vicini e lontani, dopo il saluto del rettore Paolo Mancarella.
C’erano alcuni suoi allievi, oggi emeriti italianisti, come Alberto Casadei e Natascia Tonelli; c’erano alcuni suoi colleghi come Gianfranco Fioravanti, Salvatore Settis e Amedeo Quondam, e poi altri importanti relatori, oltre ai due super ospiti: Massimo D’Alema e Pupi Avati. C’era anche l’ex-sindaco Paolo Fontanelli.
Che cosa avrebbe detto Marco Santagata di questa giornata che l’Università di Pisa gli ha dedicato, a un anno di distanza circa dalla sua scomparsa?
Non lo so, non lo conoscevo così bene. Sono più giovane di lui di circa venti anni e lui è stato uno dei miei professori in un’università che era ben diversa da quella di oggi, un’università cui sono, nella memoria, ancora affezionato.
Lui fumava le Marlboro. All’epoca il pacchetto delle Marlboro era di un solo tipo: rosso. Si dice che quelli di sinistra fumassero le Camel e quelli di destra le Marlboro. Ma, anche se il Sessantotto non lo aveva “rapito”, Marco Santagata era un uomo di sinistra. E ripensata oggi questa classificazione deve essere stata una suprema sciocchezza, pure se nel tempo della mia giovinezza pareva ancora una cosa serissima. Di certo era serissimo il modo di fumare di Santagata, che portava la sigaretta alla bocca con tutte le dita della mano e poi ti guardava da sotto in su attraverso le lenti dei suoi occhiali.
Ricordo una vecchia aula di Palazzo Ricci. L’edizione critica del Canzoniere di Petrarca indicata era quella economica, con una copertina decisamente brutta. Ricordo che insieme a me, spesso vicino di banco (se così si può dire), seguiva il corso sulla scuola siciliana anche Vinicio Pacca, col quale parlavamo dopo la lezione.
Fuori di lì forse c’era il sole, oppure avrebbe potuto piovere. Rammento solo alcuni vetri zigrinati che facevano la luce grigia.
In cattedra c’era lui, preciso, sornione, a volte stanco, ma sempre con una battuta per tenerci all’erta. Fu un anno intenso. in cui ci vedevamo almeno tre volte a settimana a lezione (compreso il seminario).
È incredibile come la morte in verità abbia già avocato a sé anche certi ricordi della giovinezza, come essi siano già in un altro mondo che non c’è più. Cominciare a “invecchiare” forse è anche dover assistere a tante trasformazioni che non riconosciamo nostre.
Infatti non pare possibile che Santagata non ci sia più. E in fondo non è vero che non c’è più, perché egli continua a vivere nei libri che ha scritto come narratore di un certo successo e sicuramente continuerà a vivere a lungo come critico massimo di Petrarca e poi riscopritore di Dante e infine – ma non ha fatto in tempo ad andare a fondo – cominciando a sedurre Boccaccio. Come ha detto nella mattinata di commiato, in cui la Sapienza sembrava come frizzata in una cartolina, la professoressa Tonelli: “Negli studi petrarcheschi c’è una netta linea di demarcazione: prima e dopo Santagata”. Un po’ come Cristo per i fedeli – e il paragone non appaia blasfemo.

Anche Pupi Avati ha dato un suo metro dell’umanità del grande critico letterario che gli fece capire Dante attraverso le dosi di dolore che il regista si è autoinflitto soltanto annunciando di volerci fare un film sopra. Ha detto: “Non sapevo che l’accesso di Dante alla poesia gli arrivò attraverso il dolore. Me l’ha fatto capire Marco. Ma in tutti avviene quasi sempre così”.
E divertentissima è stata la gaffe del regista quando ha chiesto di alzare la mano a tutti gli italianisti e i professori universitari, chiedendo loro (alcuni dantisti emeriti) se conoscessero i docenti Mazzoni e Raimondi di Bologna, cioè due colleghi. Come chiedere seriamente ad Avati se conosce Marco Bellocchio e Francesco Maselli.
Tramite Massimo D’Alema abbiamo capito che l’occupazione delle case alla fine dei Sessanta e al principio dei Settanta non era soltanto affare politico, ma anche privato, poiché il futuro Presidente del Consiglio, studente della Normale come Santagata, prese domicilio a casa sua che, al tempo aveva già con sé una compagna con il figlio. Ha detto D’Alema che “Marco aveva messo tra sé e il Sessantotto una distanza fatta di disciplina e di amore per gli studi, pure se la sua coscienza politica aveva radici profonde”.
È stato Paolo Fontanelli a ricordare un episodio buffo della storia pisana di Santagata, quando accettò di candidarsi come consigliere comunale, prendendo pochissimi voti e non raggiungendo il numero sufficiente a entrare in Consiglio.
In quella fine anni Novanta, un decennio dopo la frequentazione del suo corso universitario, ebbi modo di passare qualche tempo con Santagata. Lo feci insieme al comune amico, il “principe” Piero Floriani. Lo definisco così per il suo profilo morale, per i suoi studi di cinquecentista e per come seppe impostare una serie di progetti futuri per il Comune di Pisa, nonostante alcuni “amici” di partito vollero fargli le scarpe.
Marco Santagata, dopo l’estate del 1998, capitò spesso nell’ufficio del Sindaco, quando si sapeva ormai ufficialmente che Floriani non sarebbe stato ricandidato (a causa dell’azione protratta nel tempo dal suo partito contro di lui), per parlare della situazione intricata e infine della sua candidatura futura come consigliere, chiedendo a Piero il permesso di farlo. Un principe che chiedeva a un altro principe il permesso di abbassarsi a guardare il campo delle schermaglie minute. Queste lezioni a Palazzo Gambacorti sono equivalse a quelle di Palazzo Ricci. Anzi, forse di più.
Ma è stato Salvatore Settis a ricordare con più determinazione non soltanto lo studioso, il narratore, l’uomo, ma se vogliamo l’aspetto che più di tutti lo caratterizzava agli occhi di tanti come me che lo avevano soltanto incrociato: l’ironia e l’umanità. Settis ha preso a esempio alcuni articoli che Santagata scrisse su L’Unità a metà anni Novanta, dove si può cogliere ancora oggi l’intelligenza sottile, il sarcasmo addolcito. Come quando in un pezzo del 9 agosto 1996 prendeva in giro le mode culturali, con una specie di lettera ai figli sul tema “tormentone”. Scriveva che ancora loro, quando lui non ci fosse stato più, avrebbero continuato a sentire il tormentone letterario del gruppo ’63, almeno come eco del potere in letteratura; il tormento politico di Lotta Continua, anche solo se citata per giornalisti di gran carriera e chef sopraffini; il tormento pseudo-intellettuale de “IlmondodiPannunzio”, scritto tutto attaccato –diceva.
Marco Santagata aveva il guizzo genialoide dell’improvvisatore, come quei jazzisti che inventano da tema libero, sul palcoscenico, in una serata migliore delle altre, e rendono facile ciò che è difficilissimo e soprattutto sembra che l’abbiamo inventato proprio lì, in quel momento. Ma pochi sanno che quei jazzisti studiano giorno e notte. Così faceva Marco Santagata. Solo per permettersi di improvvisare alla grande.